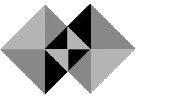Lo sviluppo della Piccola Impresa
|
Imprese: grandi o piccole?
Non c’è dubbio che, nel bene e nel male, comunque la parte più dinamica, più attiva del nostro sistema economico è la piccola e media impresa. In realtà il termine piccola e media impresa è un termine che confonde, come confonde il termine grande. Infatti, all’interno delle piccole imprese si registra un buon 15% che riesce ad avere una vita media abbastanza lunga da consolidarsi, ma c’è anche una mortalità molto alta, e anche i comportamenti sono molto differenziati. Molte delle piccole imprese decidono anche di rimanere piccole nella dizione peggiore del termine, cioè quella di dipendenza. Quindi, in realtà, gli assi sono: grande-piccolo, dipendente-autonomo. Cioè il problema dell’autonomia, nella definizione della strategia, è in qualche modo da accoppiare al problema dimensionale. D’altra parte, bisogna anche vedere il tipo di strategia da attuare. Le grandi imprese italiane, negli ultimi anni, hanno seguito una serie di strategie che sono sempre più attente a recuperare il massimo del controllo del mercato locale, piuttosto che riposizionarsi sul mercato europeo. Questo è molto chiaro per alcuni settori. Ad esempio, lo stesso settore delle auto. Nell’87 la dirigenza FIAT aveva di fronte a sé due strade: il massimo di investimento nel settore in cui erano già forti, per prendere definitivamente la leadership, o altrimenti il riposizionamento di una parte dell’accumulazione realizzata nella diversificazione verso altri settori che continuavano a promettere altre utilità, non tanto altri profitti, ma altre utilità. Quindi a livello europeo ci sono dei problemi di volume, certamente diversi da settore a settore. E ogni settore è diverso dall’altro, ovviamente. Volume produttivo e varietà produttiva. Il problema del volume è da accompagnare al problema della varietà, perché quando si parla di volume, si parla di un volume diverso da quello del passato. Oggi il volume è un aggregato di varietà, cosa che introduce degli elementi gestionali e strategici molto più complicati del passato. A livello europeo c’è una forte tendenza ad esprimere il controllo in termini non tanto di volume di produzione, ma di posizionamento in termini di volumi distribuiti. E certamente il problema principale della grande azienda, se vogliamo dare alla parola grande un’accezione positiva, non può essere più in termini di scala tecnologica, perché la scala tecnologica, per quasi tutti i settori, ha ridotto la propria incidenza nella gestione in maniera drastica. Un esempio tipico è la composizione dei quotidiani. Questo settore un tempo era quello che aveva le scale più rigide. Una produzione minima tecnica di un quotidiano dove era almeno qualcosa come 100.000 copie, a livello di stampa, per essere efficiente. Oggi invece si può fare un quotidiano decente con più o meno 8.000 copie, forse anche meno. E questo vale per tutti i settori produttivi. Più i prodotti sono sofisticati, tanto più la scala specificatamente tecnica, è sempre meno l’elemento dominante. Il prima e il dopo elemento dominante. Il vero elemento dominante è invece quello che sta prima e quello che sta dopo. Questo non vuol dire che la scala tecnica sia inessenziale. Il saper come fare a produrre è l’unico elemento di qualificazione e di posizionamento. Non c’è giapponese che tenga. Il modello di ristrutturazione, di riduzione dei costi, di miglioramento del settore incrementale costruito dalle nostre imprese in Italia, sostenuto poi anche da profitti adeguati, non ha confronti. Lo sforzo da fare, perciò, sta nel cercare il primo e il dopo. Abbiamo in Italia, proprio come risultato della specializzazione, una quantità di “settorini” che diventa sempre più difficile aggregare in grossi aggregati settoriali. Noi continuiamo ad essere abituati a ragionare su agglomerati di segmento, essenzialmente anche in termini merceologici, che non corrispondono più a quello che abbiamo di fronte. La specializzazione ha frammentato i diversi raggruppamenti, i diversi gruppi strategici, della struttura delle imprese. Non possiamo più avere, come ad esempio immaginavamo, un Centro servizi del Tessile nella stessa area regionale. Lo spettro dell’operatore è talmente frammentato, che in realtà abbiamo • quelli che fanno un utilizzo delle prime informazioni, le tendenze moda, • quelli che fanno un utilizzo delle seconde informazioni, cioè tutta la parte di incrocio sulle tecnologie dei materiali • e, terzo, quelli che si servono della parte più alta dei servizi, che sono la parte specifica di progettazione per le nuove collezioni. Il 30% dei pacemaker impiantati in Italia vengono costruiti in Italia da imprese che hanno mediamente meno di 30 addetti. Sono piccole imprese che però si sono posizionate in un settore più alto. Arrivate a un certo punto il loro problema diventerà: essere vendute (anche se essere vendute non è un dramma) oppure trovare il modo di riaggregarsi dal punto di vista della ricerca, perché o continuano ad essere semplicemente degli assemblatori, o sono assemblatori con capacità di progettazione che vanno ad interagire a livello più alto. Non si chiede a queste aziende di diventare leaders mondiali della progettazione dei pacemaker, che richiede investimenti in ricerca che probabilmente non sono in grado di fare da soli, però occorre insistere su di esse perché abbiano più capacità di progettazione, perché questo vuol dire aiutarle a spostarsi in alto nel posizionamento di assemblatori. Come si vede comincia a diventare difficile stabilire cosa vuol dire piccolo e cosa vuol dire grande. La linea in Italia non è quella di andare verso concentrazioni di imprese favorendo indiscriminatamente il problema delle fusioni e delle acquisizioni, perché ogni volta che si è forzata l’idea delle fusioni, cioè quelle che nel linguaggio politico italiano si chiamavano i poli nazionali, abbiamo creato del pasticci che non finiscono più. Questo perché ognuno ha la propria cultura. L’alternativa sarebbe quella di favorire le aggregazioni orizzontali. Ma non si possono forzare soltanto da noi in Italia, perché tanto più si specializza la produzione, e comunque ci si posizione ad un livello di estensione di mercato che è al di là di quello locale, tanto più anche i partners devono posizionarsi a quel livello. Ormai il posizionamento di mercato si consegue, non perché si abbassa il prezzo, ma perché da una parte si riesce ad offrire un servizio che è in tempo reale, dall’altra perché si è in grado di collegare la produzione alla progettazione, si è cioè in grado di offrire all’acquirente finale un prodotto che è comunque sempre in via di trasformazione, perché si è in grado di riprogettarlo in continuazione con loro. Comunque, quello che interessa è che attraverso una politica di sviluppo della piccola impresa si ricrei quella molteplicità sociale, si ricostruisca il mercato, che è l’elemento su cui riparte anche un processo di democratizzazione. Infatti, le piccole imprese fanno struttura sociale. |
La questione dell’impresa familiare.
La lettura dell’impresa familiare è la seguente. Che si voglia o no, il carattere familiare dell’impresa italiana è stato oggettivamente , in una fase di espansione, un dato positivo. Ma adesso questo può diventare una trappola infernale. Si tratta di una trappola perché, di fronte al problema di una crescita rapida, del salto, del mutamento dell’organizzazione interna, collegato in particolare anche a problemi di passaggio generazionali, c’è una forte tendenza da parte di molti imprenditori a fare un passo indietro. Se si va a guardare la gestione della liquidità interna delle imprese italiane, si vede che sono straordinariamente liquide. Non c’è nessuna impresa al mondo che ha la liquidità delle nostre imprese. Le nostre imprese, almeno nel recente passato, sono state tanto piene di soldi che non sapevano dove metterli. Nessuno meglio degli addetti al sistema bancario ne è più consapevole. Il vero problema è che generalmente le nostre imprese piccole e medie sono sottocapitalizzate, perché hanno delle strutture di mezzi propri che rimangono sostanzialmente quelli iniziali. Hanno una gestione del portafoglio che generalmente non esiste o è ridotta all’alternativa tra investire direttamente o comprare dei BOT o comprare comunque delle cose collegate. Hanno il più delle volte una commistione fra patrimonio personale e patrimonio d’impresa che fa sì che in situazioni di pericolose preferiscono rimanere liquidi, pur di avere sempre delle alternative. Allora, la iperliquidità delle imprese italiane non è un problema che possiamo ridurre più o meno al fatto che queste siano “furbe” o “meno furbe”. È vero, invece, che hanno una struttura patrimoniale e una struttura gestionale che è molto più arretrata del tipo di conoscenze tecnologiche che hanno nel loro settore specifico. Questa è una spiegazione ragionevole che accoppia elementi di una situazione generale italiana in cui il problema della esistenza di un deficit pubblico a questo livello falsa tutti i valori: non bisogna dimenticare questo passaggio. Se un’azienda, per esempio, ha dei BOT che vengono dati ad un tasso completamente diverso rispetto al rendimento possibile di qualsiasi rendimento industriale, è ovvio che l’imprenditore preferisce tenere i BOT anziché investire; quanto più si va verso situazioni di incertezza, tanto più si preferisce tenere i soldi anziché investire. Questo è ovvio, ma è chiaro come questo sia un grosso problema. Le imprese debbono mobilizzarsi. Io su questo sono molto sereno, tanto è vero che il vero problema delle nostre imprese è che queste continuano a configurarsi come imprese di produzione, mentre io sono convinto (e questo è un nocciolo fondamentale) che quello che noi dovremmo fare sarebbe indurre tante imprese, familiari per conduzione (non tutte, ma una serie), a riuscire a mobilizzarsi. Sono convinto che il problema che noi avremo di fronte nei prossimi anni sarà proprio questo: noi dobbiamo trovare o via mercato ed istituzioni o via istituzioni-norma il modo per permettere a molte famiglie di spostare la loro attività in una struttura di holding finanziaria e di fare i proprietari e basta. Se Arturo Ferruzzi sostiene di non essere un manager, abbiamo trovato un padrone che fa il padrone, padrone nel senso che è proprietario di un patrimonio finanziario, lo modifica come gli pare in quanto è libero di modificarlo come gli pare; ma il destino della MONTEDISON è un’altra cosa! Noi stiamo elgando oggi molte bellissime imprese italiane ai problemi di difficoltà gestionale di una transizione da patrimonio familiare a struttura di portafoglio che è oggi un vincolo drammatico. Questo sarà il tema del prossimo convegno a Capri dei giovani industriali: questo è un problema cruciale, dopo di che se uno vuol fare il manager lo fa e basta, meglio per lui se lo può fare, ma non è questo il problema. Il problema è che oggi noi siamo incastrati in una piccola struttura che è una struttura patrimoniale semplice, una struttura di comando baanale, una struttura tutto sommato di produzione e che invece è straordinariamente sofisticata. Anche sui consorzi e su chi deve gestire i servizi reali, io, tutto sommato, vi invito a non farvi incastrare da strutture di rigidità, perché sono convinto che ci possono essere delle situazioni in cui il consorzio serve; se ci sono problemi banalmente di contrattazione di più soggetti in termini più o meno istituzionali, può darsi che il consorzio funzioni bene. Io francamente metterei in consorzio tutte le attività che non sono strettamente rilevanti per il mio posizionamento strategico a termine. Tanto più ho problemi di una definizione di un qualche tipo di assett che sia cruciale per il mio posizionamento strategico a breve, tanto meno lo metto in conzorzio. Allora vuol dire che contemporaneamente favorirei il consolidamento per i consorzi e però favorirei gli incroci possibili, i più aperti possibile. Cioè, ben vengano le aggregazioni di consorzi tra due imprese italiane e due imprese che stanno in Germania. Stesso discorso per i servizi: ci sono dei servizi che se venissero fatti da tutti andrebbero benissimo; vuol dire che l’ente pubblico si mette da parte e non li fa. Ma ci sono dei servizi che, sono convinto, l’ente deve fare, che sono quelli che naturalmente non si attivano. Ci sono delle cose che proprio devono essere fatte; né il singolo, né la singola associazione possono farle. Ci sono cose che possono essere date da tutte le associazioni, da tutti. L’Università. Dobbiamo auspicare che la parte fondamentale dell’imprenditoria nei prossimi anni non lascerà più, come è successo finora, che in una fabbrica di produzione un operaio si stacchi e metta su la sua fabbrichetta perché ha imparato a fare una certa cosa, il cosiddetto spin off. Dobbiamo, invece, puntare, come in tutti i paesi del mondo, affinché una parte di imprenditoria nasca dalle Università, o comunque da attività parauniversitarie. Perché è quello il patrimonio giusto di conoscenze che bisogna riuscire a mobilitare. Ma anche in questo caso, non si può prendere la mappa, dividerla in quadratini, vedere qual’è l’attività prevalente in ogni quadratino e lì costituire il Centro servizi corrispondente, perché questo tipo di operazione diventa poi una trappola, una gabbia da cui è difficile uscire. Il bandolo della matassa è legato alle nostre capacità di produzione, però queste si sono differenziate. Quello che viene prima e quello che viene dopo è fondamentale. Si possono avere per diversi gruppi dei tipi di suggerimenti diversi. Però bisogna stimolare molto la nascita anche di nuove attività di terziario, nel senso di grande e piccolo terziario, cioè di capacità di cumulare delle conoscenze, perché poi alla fine il terziario va anche ricostruito. Non è detto che dappertutto debba esserci tutto. Ci possono essere delle attività che sono incentrate soltanto in alcuni luoghi. Ormai ci sono tipi di terziario che si trovano solo a Londra. Ma questa non è una difficoltà, purché chi ha sede qui possa servirsi di quel Centro servizi di Londra. |