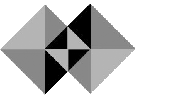Il 1960. Un anno cruciale Il 1960 lo si ricorda in genere per le grandi manifestazioni
antifasciste, di protesta che si svolsero i primi
di luglio, contro il governo Tambroni che aveva
autorizzato il Movimento Sociale Italiano a tenere
il suo congresso a Genova, città medaglia d 'oro
della resistenza.
Il 1960 lo si ricorda in genere per le grandi manifestazioni
antifasciste, di protesta che si svolsero i primi
di luglio, contro il governo Tambroni che aveva
autorizzato il Movimento Sociale Italiano a tenere
il suo congresso a Genova, città medaglia d 'oro
della resistenza. Nel corso di quelle manifestazioni che avvennero in tutta Italia, anche al sud, perirono in scontri con la polizia alcune decine di dimostranti, e più di un centinaio rimasero feriti. Ma il 1960 fu un anno cruciale perché segnò il tramonto di un 'ìintera stagione politica, quella dei governi centristi. La coalizione della Democrazia Cristiana con i liberali, i repubblicani, i socialdemocratici, che dal 1948 si era avvicendata alla guida del Paese, non era più risuscitata, dopo che i liberali avevano ritirato nel febbraio del 1960 il loro appoggio al governo presieduto allora da Antonio Segni. Tuttavia, non sembrava in quel momento che si fosse di fronte ad una svolta politica autentica. Nenni aveva sganciato il partito socialista dai rapporti collaterali con il partito comunista, dopo che nel novembre 1956 Togliatti non aveva condannato la repressione sovietica in Ungheria della rivolta popolare. Ma nelle elezioni amministrative del 1960 la DC aveva pagato uno scotto molto salato in seguito all 'epilogo del centrismo, perdendo circa un milione di voti a favore dei liberali. D’altro canto ci si chiedeva quali sarebbero state le ripercussioni dei nostri rapporti con gli Stati Uniti qualora si fossero aperte le porte ai socialisti, in quanto i socialisti erano rimasti su posizioni per lo più neutraliste, comunque critiche nei confronti del patto Atlantico. È vero che alla Casa Bianca stava per salire il leader democratico John Kennedy, ma non si sapeva quali sarebbero stati gli orientamenti della nuova amministrazione americana, e per di più dal Vaticano, si continuava ad ammonire i dirigenti della Dc a non collaborare con il partito socialista, in quanto ispirato a principi marxisti. Si era dunque nel mezzo di una situazione politica estremamente fluida e piena di interrogativi e dagli sviluppi imprevedibili. La grande corsa dell’economia  Se la politica arrancava, ben diverso era invece
lo scenario all 'esterno di quel mondo. Il sistema
economico marciava a pieno regime, la gente era
rinfrancata dall 'incremento dei posti di lavoro,
e anche dei consumi, e ci si era infine dimenticati
degli anni bui del dopoguerra quando il paese era
ridotto in brandelli.
Se la politica arrancava, ben diverso era invece
lo scenario all 'esterno di quel mondo. Il sistema
economico marciava a pieno regime, la gente era
rinfrancata dall 'incremento dei posti di lavoro,
e anche dei consumi, e ci si era infine dimenticati
degli anni bui del dopoguerra quando il paese era
ridotto in brandelli. Nel 1960 l 'Italia aveva potuto fregiarsi anche di un importante riconoscimento in campo finanziario. Dopo che era stato un giornale inglese The Guardian a definire con il termine “miracolo economico” il processo di sviluppo allora in atto nel nostro paese, dalla Gran Bretagna era giunto un altro attestato prestigioso per le credenziali dell 'Italia. Il Financial Times aveva attribuito alla lira l’oscar della moneta più salda fra quelle del mondo occidentale. Un premio che aveva coronato una lunga e affannosa rincorsa, iniziata nell'immediato dopoguerra con i provvedimenti di Luigi Einaudi per scongiurare la bancarotta e non naufragare fra i marosi dell'inflazione. Di conseguenza si era potuto stabilizzare il cambio con il dollaro a quota 625, e la rivalutazione delle riserve auree della Banca d 'Italia era servita a ridurre l 'indebitamento del Tesoro. Di qui l 'ondata di euforia che si era sparsa in borsa con i listini decisamente in rialzo. Ebbene, solo fino a poco tempo prima nessuno si sarebbe immaginato che l 'Italia avrebbe potuto conseguire un successo economico dopo l 'altro. È vero che grazie agli aiuti americani del piano Marshall l 'opera di ricostruzione postbellica era avvenuta più rapidamente del previsto, sostanzialmente entro la fine degli anni 40 e primi mesi del 50, ma l 'Italia era rimasta pur sempre un paese prevalentemente agricolo, con una gran massa di braccianti e di coloni. Nord e Sud  Questa
era l’Italia delle campagne non soltanto del Mezzogiorno
ma anche del Nord. Soltanto nel Nord-Ovest e in
qualche località del Nord Est nel Veneto, in Emilia,
in Toscana, erano attive alcune grandi fabbriche.
Nel resto della penisola si aveva a che fare con
un economia per lo più di sussistenza. Questa
era l’Italia delle campagne non soltanto del Mezzogiorno
ma anche del Nord. Soltanto nel Nord-Ovest e in
qualche località del Nord Est nel Veneto, in Emilia,
in Toscana, erano attive alcune grandi fabbriche.
Nel resto della penisola si aveva a che fare con
un economia per lo più di sussistenza. In alcune zone del sud si viveva alle prese con una miseria endemica. Ma pure al Nord si viveva fra non pochi stenti e molti dilemmi. In Piemonte in Liguria nel comasco e nel Veneto si erano appena riparati i grandi danni provocati dalle piogge e dalla grande alluvione del novembre del 1951 che era stata un 'autentica tragedia soprattutto per il Polesine, dove erano morte un centinaio di persone e quasi 200.000 avevano dovuto abbandonare le loro case. Insomma non era certo tutto rose e fiori anche al Nord, ed è vero che nel frattempo il sesto governo de Gasperi aveva varato nel 1951 una riforma che aveva interessato soprattutto il Sud (ma anche la Maremma e altre zone) e aveva istituito la Cassa per il Mezzogiorno, all 'insegna di un intreccio fra istanze solidaristiche di matrice cattolica, e precetti di matrice Keynesiana. Erano poi seguiti diversi provvedimenti per lo sviluppo dei trasporti ferroviari, l 'espansione della rete dei metanodotti, della cantieristica, delle telecomunicazioni e anche varie agevolazioni per il credito a tasso ridotto, a favore delle piccole imprese. Queste e altre misure avevano certamente contribuito a ridurre la disoccupazione, ad ampliare la base produttiva, e anche l 'area dei servizi, e anche a rendere più consistente la domanda interna. Tuttavia non si pensava che l 'economia italiana potesse volare molto in alto. Un retaggio pesante  Il
nostro era pur sempre un paese privo di materie
prime, insufficienti al fabbisogno, con scarse risorse
energetiche, senza molti capitali di rischio, e
quanto esportava consisteva per lo più in derrate
agricole e in prodotti semilavorati. Il
nostro era pur sempre un paese privo di materie
prime, insufficienti al fabbisogno, con scarse risorse
energetiche, senza molti capitali di rischio, e
quanto esportava consisteva per lo più in derrate
agricole e in prodotti semilavorati. E si spiega pertanto come ancora nel 1954, alla fine del 54, il piano Vanoni, dal nome del Ministro delle Finanze che lo aveva concepito, facesse affidamento soprattutto sull’espansione dell'edilizia, legata per tanti versi ancora alle opere di ricostruzione, sullo sviluppo delle opere pubbliche, sull'incremento delle rimesse dei nostri emigrati all 'estero, in Francia in Belgio in Svizzera. E tutto questo per assicurare nel giro di un decennio un posto di lavoro a tutti, ridurre il dualismo fra il Nord e il Sud, e pareggiare la nostra bilancia dei pagamenti. Il Mercato Comune Europeo In realtà la prospettiva del MEC - Mercato Comune Europeo non aveva suscitato all'inizio aspettative tali da controbilanciare le forti riserve espresse da alcuni settori dell 'industria pesante, dell'industria siderurgica, ma anche da gran parte dell'industria meccanica e automobilistica, che erano preoccupati di non farcela a sostenere l 'urto della concorrenza straniera. Del resto erano stati scarsi, allora i benefici per l 'Italia derivanti dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA, a cui noi avevamo aderito nel 1951. A trarre i maggiori benefici da questi accordi erano state la Francia e la Germania. Occidentale. Di fatto la decisione che aveva portato il governo italiano a sottoscrivere il trattato di Roma, era apparsa a molti una scelta temeraria, una scelta azzardata, legata più a motivazioni di ordine politico, motivi di politica estera, al fatto cioè che occorreva riabilitare l 'Italia nel consesso internazionale, che da calcoli economici. Sennonché, proprio nel 1958 l 'anno in cui entra di fatto in vigore il trattato della CEE, divennero sempre più robusti e intangibili i segnali che attestavano una notevole crescita della economia italiana. Il prodotto interno lordo quell'anno crebbe in termini reali, intorno del 6,6%. Gli scambi commerciali registrarono per la prima volta dal dopoguerra un forte saldo attivo, grazie ad un notevole incremento delle esportazioni., Aumentò il flusso nel nostro paese di investimenti esteri. La Banca d 'Italia ridusse il tasso di sconto dal quattro al 3.50 per cento. Il boom economico Ci si chiede quali furono i fattori che posero le premesse del boom economico, del miracolo economico, come venne definito all'estero e che avrebbe continuato ad agire da propellente per altri cinque anni fino al 1962-63 (poi ci sarà una congiuntura recessiva. Ancora oggi si ritiene che l 'eccezionale crescita economica di quegli anni vada attribuita alla disponibilità di un vasto serbatoio di manodopera a basso costo, rispetto ai costi praticati dai nostri concorrenti stranieri. Ed è certamente vero che questa circostanza si risolse in un vantaggio competitivo di non poco conto, per l 'industria italiana, soprattutto per la grande industria. Ma da sola una dinamica dei salari inferiori a quella dei concorrenti non sarebbe stata sufficiente a dare le ali alle principali imprese industriali, che svolsero allora una funzione trainante per l 'intero sistema paese. Altri fattori contribuirono a mettere in moto e ad assecondare lungo la strada, l 'intenso processo di sviluppo che avvenne in quegli anni. Innanzitutto ebbe a contare l’adozione in alcuni grandi stabilimenti di attrezzature e tecnologie innovative già collaudate con successo nei paesi più avanzati in particolare negli Stati Uniti. Questo consentì di accrescere abbastanza rapidamente gli indici unitari della produttività. Inoltre il trend dei prezzi delle materie prime, in particolare del prezzo del petrolio e delle altre materie prime, rimase relativamente costante dopo che finì la guerra in Corea, nell'estate del 1953. Durante i tre anni dal 1950 al ‘ 53 in cui fiorì il conflitto nella penisola coreana i prezzi delle materie prime invece schizzarono molto in alto, e il nostro paese ne fu certamente danneggiato. Perché noi eravamo privi di risorse minerarie, carenti di combustibile, ma anche di prodotti come lana e cotone che servivano alla nostra industria tessile che allora aveva un ruolo preminente rispetto all'industria meccanica, che poi la sorpassò. Altrettanto preziosa risultò l 'utilizzazione di nuove fonti energetiche, soprattutto il metano e ancora la diffusione di centrali termo-elettriche, non soltanto di quelle idroelettriche. Noi eravamo, prima della guerra, il terzo paese come potenzialità soprattutto del settore idroelettrico, e negli anni 50 si sviluppano soprattutto centrali termo elettriche. Un Paese di risparmiatori  Infine,
ma non da ultimo, il livello piuttosto contenuto
dei tassi di interesse. La Banca d 'Italia aveva
ridotto il tasso al 3,5%, di conseguenza il costo
del denaro rimase relativamente basso, almeno rispetto
ad altri paesi, e questo dette impulso agli investimenti. Infine,
ma non da ultimo, il livello piuttosto contenuto
dei tassi di interesse. La Banca d 'Italia aveva
ridotto il tasso al 3,5%, di conseguenza il costo
del denaro rimase relativamente basso, almeno rispetto
ad altri paesi, e questo dette impulso agli investimenti.
A rendere possibile questo trend fu un 'opera veramente capillare di raccolta di piccoli depositi da parte delle Casse di Risparmio molto diffuse nel nostro paese. Questo era un vantaggio perché altri paesi, fatta eccezione per la Francia, non avevano una rete così diffusa di Casse di Risparmio. Da noi anche il risparmio postale ebbe un ruolo decisivo. Molta gente, soprattutto i meno abbienti, depositava quel poco che gli rimaneva, dopo essersi assicurata i beni essenziali di prima necessità, presso gli sportelli della posta. La Banca d’Italia  Ma
c’è anche da registrare una severissima azione di
controllo e di vigilanza della Banca d 'Italia a
presidio della stabilità della moneta. Nel 1960
avevamo raggiunto questo traguardo molto ambito
dell’Oscar della moneta. Ma
c’è anche da registrare una severissima azione di
controllo e di vigilanza della Banca d 'Italia a
presidio della stabilità della moneta. Nel 1960
avevamo raggiunto questo traguardo molto ambito
dell’Oscar della moneta. Governatore della Banca d 'Italia era allora un personaggio che aveva fatto molto bene all’Iri, Donato Menichella. Il Governatore utilizzò le riserve e le valute pregiate, di cui la Banca d 'Italia disponeva, con molta sagacia, per garantire l 'equilibrio della Bilancia dei pagamenti, e così la nostra crescita economica poté avvenire senza forti tensioni inflattive. Questo fu lo snodo decisivo, perché la nostra economia cresceva in termini reali e cresceva in termini reali anche il potere d 'acquisto della gente. La rivoluzione silenziosa  Certo il miracolo
economico fu dovuto a molteplici altri fattori fra
cui va inclusa certamente una congiuntura positiva
a livello internazionale. Certo il miracolo
economico fu dovuto a molteplici altri fattori fra
cui va inclusa certamente una congiuntura positiva
a livello internazionale.Questa congiuntura aveva favorito specialmente l’Europa, meno gli Stati Uniti, sia sulla scia della ricostruzione postbellica, sia in seguito alla liberalizzazione complessiva degli scambi nel mondo occidentale. Però va sottolineato in particolar modo quello che è stato uno dei maggiori fattori del miracolo economico, cioè la rigorosa, tenace, paziente, opera di due generazioni di italiani, che dopo tante sofferenze, tante privazioni, speravano in una sorte migliore per sé e per i propri figli. Una speranza, una fiducia nel futuro. Gli italiani allora erano divisi da forti contrapposizioni politiche, ideologiche. Ma nonostante gli anni della guerra fredda, c 'era una sorta di comune denominatore che in pratica era una cifra di identità per tutti gli individui. Una grande voglia di riscatto, una grande voglia di fare, di emancipazione sociale, insieme a un robusto spirito di iniziativa e un forte senso di fiducia nell 'avvenire, da parte di uomini e donne, una generazione che aveva vissuto una dittatura e una guerra mondiale spaventosa. Un fenomeno non meglio definibile che come rivoluzione silenziosa. Un termine che fotografa abbastanza bene lo stato d 'animo e la sensibilità e la mentalità degli italiani di allora. Il valore che governava questa rivoluzione silenziosa era il lavoro, era il lavoro da cercare, il lavoro da difendere, il lavoro da fare. Questo era in cima ai codici individuali e quasi traduceva in pratica quello che era il dettato dell’art. 1 della nostra Costituzione: una Repubblica fondata sul lavoro. La mano pubblica e la mano privata La marcia in più innestata dall 'economia italiana si doveva alla convergenza che si era venuta realizzando lungo la strada, fra mano pubblica e mano privata. Ossia fra le imprese a partecipazione statale, e quelle dei principali gruppi del capitalismo familiare. È pur vero che nell'immediato dopoguerra erano stati in molti a ritenere che le aziende, le banche passate a suo tempo nel sanatorio del Iri in seguito alla grande crisi mondiale del 1929, avrebbero dovuto essere liquidate e smobilitate. In primo luogo i liberisti. E gli uomini di pensiero liberista erano in maggioranza a quel tempo nelle accademie, nelle università, oltre che nei giornali. Insieme a questi anche vari esponenti della Democrazia Cristiana. Nonché gran parte della sinistra che, trainata da Togliatti, considerava l’Iri un autentico carrozzone, retaggio della politica autarchica, militarista e militarizzata del regime fascista. Le imprese pubbliche Le imprese statalizzate avevano raggiunto sotto il fascismo, nel loro complesso, una consistenza talmente ampia, che l 'Italia risultava seconda solo all'Unione Sovietica per grado ed entità di statalizzazione dell’ economia, tanto nell'industria, che nelle banche. Di fatto, se il settore pubblico riuscì a sopravvivere, ciò dipese soprattutto dal ritorno a casa di una grande massa di reduci. Tornavano i reduci, e c’era l 'esigenza di trovare nuovo lavoro per tutti e di salvare il posto di lavoro per quelli che ce l’avevano ancora. Non che si facesse molto affidamento sulle capacità competitive del settore economico pubblico. Infatti molte di queste imprese che lo Stato si era assunto a carico erano fallite per tante ragioni, e si pensava che molte altre sarebbero fallite, specialmente quelle, ed erano molte, . legate direttamente o indirettamente alla produzione di armamenti, e che avrebbero avuto costi di riconversione. una volta finita la guerra. Invece l’IRI fu riorganizzato sulla base di un nuovo Statuto nel 1948, e le aziende dell’Iri diedero prova di grande vitalità e di grande dinamismo. In particolare l’Eni che aveva raccolto l 'eredità dell'Agip, fondata nel 1926, che era stata sul punto di essere liquidata, se non fosse stato per l 'ostinazione di Enrico Mattei. Mattei, in qualità di leader delle formazioni partigiane bianche, cioè le formazioni partigiane della Democrazia Cristiana, aveva voce in sede politica. De Gasperi, Vanoni e Fanfani furono i suoi interlocutori. Forte di questi appoggi Mattei diede prova di grande sagacia e intraprendenza, (ma decisive furono anche una certa disinvoltura e spregiudicatezza), nel trasformare l 'Eni, un Ente di Stato, in un sistema asse portante del nostro sistema energetico nazionale, attraverso varie iniziative all 'estero, a cominciare da quella intrapresa con l 'Iran, con la formula della fifty-fifty. La simbiosi industriale Così si era venuta formando una sorta di simbiosi, termine usato da Raffaele Mattioli, grande banchiere e allora leader della Banca Commerciale Italiana, tra la mano privata e la mano pubblica. La mano pubblica includeva i settori di base, come la siderurgia, la cantieristica, i settori telefonici, le risorse energetiche. La mano privata includeva per lo più i settori dei beni di consumo durevoli, dalle automobili agli pneumatici, dai motoscooters agli elettrodomestici, dai prodotti tessili a quelli chimici, dalla plastica alle macchine da scrivere e alle macchine contabili. Dietro ognuno di questi prodotti si poteva mettere una sigla, una grande impresa che era una sorta di capofila, poi, a seguire, una serie di aziende controllate o partecipate nella filiera della propria produzione. Questa combinazione tra la mano pubblica e la mano privata non si era sfilacciata nemmeno dopo che nel 1957 la Democrazia Cristiana aveva deciso lo sganciamento delle imprese dell’Iri dalla Confindustria, a cui le imprese pubbliche e quelle private avevano fatto capo fino ad allora. Una sconnessione, uno sfilacciamento che non avvennero mai perché queste aziende erano in effetti complementari. Per avere un 'idea di quante fossero le sinergie tra l 'una e l 'altra, basterà pensare che grazie alla produzione di laminati piani a prezzi decrescenti da parte delle aziende pubbliche come la Finsider di Oscar Sinigaglia, che si erano convertite al ciclo integrale (cioè dalle materie prime al prodotto finito), le imprese meccaniche private, automobilistiche, meccanica di precisione, meccaniche in genere, avevano potuto diventare il settore di punta dell’industria italiana, soppiantando quella che era stata fino ad allora una sorta di punta di diamante della nostra industria, cioè l’industria tessile. Non solo: fra l’Eni di Mattei e la Fiat di Vittorio Valletta, si era venuta a creare una confluenza di interessi e di obiettivi, in quanto l’importazione di petrolio e la costruzione di una rete di distributori di carburante sulle autostrade, e fuori dalle autostrade, assecondavano lo sviluppo di una incipiente motorizzazione di massa. Enrico Cuccia e Mediobanca E come dimenticare una banca singolare come Mediobanca. Mediobanca, istituita nel 1946 dalle tre banche di interesse nazionale, Banca Commerciale, Credito Italiano e Banco di Roma, sotto la regia di Enrico Cuccia, era diventata in pratica da crocevia e da perno delle relazioni e dei rapporti fra i principali gruppi dell’IRI e i principali gruppi del capitalismo familiare. Nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca figuravano i rappresentanti delle principali dinastie private e naturalmente i principali esponenti dell’IRI, ma di fatto il potere decisionale fu consegnato al Management impersonato da Enrico Cuccia, grande e unico protagonista della grande finanza fino agli anni ‘90. Una economia mista Di fatto, quella italiana era diventata una sorta di economia mista. Fra capitalismo privato e capitalismo pubblico a livello istituzionale, operativo. Un’economia mista diversa da quella del periodo fascista. Durante il periodo fascista l’intervento pubblico si era espanso a tal punto che, come si diceva, nell’Italia fascista si calcolava che fosse superiore addirittura a quello della Russia sovietica comunista. Però quella fascista era una economia mista di emergenza. Era stata creata per salvare il salvabile. Con il crack della Banca Romana, Mussolini temette che il crollo delle Banche avrebbe travolto, insieme al mondo delle imprese, in cui le Banche avevano delle forti immobilizzazioni, il mondo politico. C’era il forte rischio del crollo dell’economia italiana, che quindi avrebbe portato infine anche al crollo del regime. Da lì una serie di misure di straordinario impatto positivo. Invece il sistema di economia mista, quale si era andato a formare nei prima anni ’50, aveva la sua ragion d’essere in una serie di connessioni, di interdipendenze di carattere funzionale. Non c’erano, non c’erano sovrapposizioni. Tutto aveva una sua funzionalità. E questo tutto aveva contribuito sia alla crescita di statura dell’industria italiana, mai presente prima in forza in tutti i settori, che alla espansione delle nostre esportazioni nei circuiti internazionali. Questi risultati non sarebbero stati conseguiti, se mano pubblica e mano privata avessero operato ognuno per conto proprio in ordine sparso. E invece era avvenuto che la mano pubblica si era addossato l’onere dei settore di base, che erano i settori ad alta intensità di capitale e a redditività differita nel tempo, anche 5 10 anni. E aveva assunto anche l’ onere della costruzione di adeguate infrastrutture ed economie esterne. Così l’industria privata, avvalendosi di un complesso di beni primari e di economie esterne, era stata in grado di accrescere le proprie chances, puntando su un ventaglio di prodotti caratterizzati da una domanda composita ed elastica, come era appunto quella dei beni di consumo durevoli che trovava soprattutto sui mercati europei grandi e crescenti sbocchi, perché questi mercati europei, la Francia, la Germania, l’Inghilterra erano paesi con un più alto livello di redditi e di consumi. Il boom dei beni di consumo durevoli si ebbe in Italia nei primi anni 60, favorito dalla crescente esportazione di questi prodotti all’estero, soprattutto nell’ambito del mercato comune. Un Paese esportatore  In
pratica grazie a queste leve il nostro paese si
trasformò da un paese in gran parte autarchico come
quello che ci aveva lasciato in eredità il regime
fascista, in una economia trainata dalle esportazioni.
Ancora oggi, se ad esempio la Germania o un altro
paese europeo, innescano una marcia più alta, la
nostra industria incrementa le esportazioni verso
l’Europa. I prodotti che cominciammo ad esportare
erano autoveicoli, elettrodomestici, apparecchi
e strumenti di precisione, fibre sintetiche, materie
plastiche. Non solo più l’olio, la pasta, gli agrumi,
o i prodotti artigianali, che erano prima di allora
l’unica arma di cui disponevamo nei circuiti internazionali. In
pratica grazie a queste leve il nostro paese si
trasformò da un paese in gran parte autarchico come
quello che ci aveva lasciato in eredità il regime
fascista, in una economia trainata dalle esportazioni.
Ancora oggi, se ad esempio la Germania o un altro
paese europeo, innescano una marcia più alta, la
nostra industria incrementa le esportazioni verso
l’Europa. I prodotti che cominciammo ad esportare
erano autoveicoli, elettrodomestici, apparecchi
e strumenti di precisione, fibre sintetiche, materie
plastiche. Non solo più l’olio, la pasta, gli agrumi,
o i prodotti artigianali, che erano prima di allora
l’unica arma di cui disponevamo nei circuiti internazionali.I dati stanno a testimoniare del successo di questa svolta. Fra il 1958 e il 1963 il nostro movimento commerciale con l’estero, in media, crebbe del 16% ogni anno. Quello verso i paesi del mercato comune europeo registrò un incremento del 25%. L’adesione al mercato comune si rivelò così a posteriori non più una scelta azzardata, una scelta che ci aveva gettato nel panico quando, nel 1959, si era cominciato a ridurre del 50% i dazi doganali all’interno dei paesi della CEE. L’Italia divenne un Paese esportatore di prodotti finiti. L’indice di crescita del prodotto interno lordo superò nel 1961 l’8 e mezzo per cento. Soltanto la Germania occidentale, era riuscita a fare meglio di noi, ma di poche frazioni di punto. In virtù di questi progressi e di altri, noi riuscimmo a ridurre notevolmente i divari di partenza con l’Inghilterra e la Francia. La rincorsa era cominciata dai tempi di Cavour, dai tempi del nostro Risorgimento, dai tempi della nostra unificazione nazionale, ma il divario invece di ridursi si era accresciuto strada facendo, a parte i 10 anni fortunati dell'età giolittiana all’inizio del secolo. Sopravanzammo anche Paesi come il Belgio e l’Olanda che ci avevano nel frattempo superato di parecchie lunghezze. In più l’Italia stava per diventare il terzo paese mondiale per potenza elettronucleare in esercizio. Questa è una circostanza che pochi ricordano, ma allora avevamo 5 impianti elettronucleari in funzione o in costruzione. |
Il rovescio della medaglia. I mali del Sud Ma il miracolo economico non fu un prodotto omogeneo, privo di scompensi, di contraddizioni, di sfasature. Soltanto una parte ristretta del Paese, soprattutto il Nord-Ovest, aveva conosciuto un autentico decollo industriale. Il Sud continuava perlopiù a vegetare nell’ambito di una economia molto gracile e in gran parte assistita. La questione meridionale, per cui si erano battuti Giustino Fortunato e Gaetano Salvemini, era in effetti la questione dell’accesso alla piccola proprietà agricola.  L’allora Ministro
dell’Agricoltura Antonio Segni riuscì a condurre
in porto questa essenziale riforma e fu il vero
protagonista di questo evento epocale. L’allora Ministro
dell’Agricoltura Antonio Segni riuscì a condurre
in porto questa essenziale riforma e fu il vero
protagonista di questo evento epocale.Ma le cose non andarono come si sperava. Per accontentare il maggior numero possibile di capifamiglia, di contadini, di assegnatari, si finì per distribuire piccole porzioni di terra, in media di 3-4 ettari su terreni argillosi sassosi, che dei latifondi erano la parte meno fertile. Dopo un po’ queste terre non produssero reddito bastante a queste famiglie di contadini che a costo di tante lotte, sembravano avere infine conseguito un traguardo secolare. Questo non fu solo il risultato di un calcolo politico della Democrazia Cristiana e del Ministro. Anche socialisti e comunisti fecero pressioni in quel senso, perchè avevano timore che tutto sommato si creasse un spaccatura tra i braccianti, cioè tra quelli che rimanevano senza terra e quelli che riuscivano ad ottenere un pezzetto di terra. In pratica ci si trovò d’accordo nel cercare di accontentare tutti. Il governo di allora, su pressione dell’opposizione, su sollecitazioni interne, si dette da fare anche per migliorare le condizioni ambientali del Mezzogiorno. C’erano stati provvedimenti della Cassa per il Mezzogiorno che riguardavano soprattutto la costruzione di infrastrutture: acquedotti, fognature, strade. Insomma, opere pubbliche essenziali perché si pensava che questi fossero i requisiti per lo sviluppo economico. Poi era stato imposto all’IRI e all’ENI di destinare almeno il 40%, talvolta anche il 60%, dei nuovi investimenti nel Mezzogiorno. Certo, non sarebbe stato possibile trasformare come d’incanto intere plaghe come quella del Mezzogiorno, rimaste per tanto tempo nel limbo del sottosviluppo, in zone ad alto sviluppo industriale.  Ma va osservato che per innescare
un autentico processo di sviluppo alto propulsivo,
sarebbe stata necessaria la presenza di una piccola
e media borghesia con attitudini imprenditoriali
e non invece caratterizzata soprattutto da una vocazione
impiegatizia. Lo aveva già detto Salvemini e purtroppo
le cose non cambiarono negli anni ’50 e ’60. Ma va osservato che per innescare
un autentico processo di sviluppo alto propulsivo,
sarebbe stata necessaria la presenza di una piccola
e media borghesia con attitudini imprenditoriali
e non invece caratterizzata soprattutto da una vocazione
impiegatizia. Lo aveva già detto Salvemini e purtroppo
le cose non cambiarono negli anni ’50 e ’60.
La conseguenza fu che, nonostante questi sforzi enormi, andò crescendo, insieme alla emigrazione verso l’estero che era già partita dal ’46-47-48, anche l’esodo di tanta gente in cerca di lavoro e di fortuna verso le roccaforti industriali del Nord. Ci sono dei dati impressionanti. Dal ’51 al ’61 le regioni del Mezzogiorno persero quasi 1.800.000 abitanti, in età fra i 20 e 40 anni, cioè in età adulta e produttiva, oltre metà dei quali si stabilì nell’Italia settentrionale. Trovavano lavoro, ma non sempre un tetto. La ventata di benessere al Nord e al Centro  L’altra
parte d’Italia stava vivendo una prima ventata di
benessere, una ventata di sviluppo dell’economia,
sviluppo dell’occupazione. Al Nord soprattutto,
ma anche in altre parti d’Italia tra il Nord e il
Centro, si concentrarono le principali imprese,
ed erano presenti anche i principali servizi di
interesse collettivo. Lì si stava assistendo non
soltanto ad un incremento dell’occupazione, ma anche
ad un sensibile miglioramento delle condizioni di
vita. Nelle case della gente stava entrando un sempre
maggior numero di beni di consumo durevoli. I frigoriferi
prima di tutto, le lavatrici, gli impianti a gas,
gli apparecchi televisivi, le macchine da scrivere
e contabili, e poi anche molti oggetti di uso comune.
Inoltre, era cominciata la motorizzazione di massa
con la Fiat 500 che usci nel 1955, la 500 del 1957,
poi arrivò la 1100. L’altra
parte d’Italia stava vivendo una prima ventata di
benessere, una ventata di sviluppo dell’economia,
sviluppo dell’occupazione. Al Nord soprattutto,
ma anche in altre parti d’Italia tra il Nord e il
Centro, si concentrarono le principali imprese,
ed erano presenti anche i principali servizi di
interesse collettivo. Lì si stava assistendo non
soltanto ad un incremento dell’occupazione, ma anche
ad un sensibile miglioramento delle condizioni di
vita. Nelle case della gente stava entrando un sempre
maggior numero di beni di consumo durevoli. I frigoriferi
prima di tutto, le lavatrici, gli impianti a gas,
gli apparecchi televisivi, le macchine da scrivere
e contabili, e poi anche molti oggetti di uso comune.
Inoltre, era cominciata la motorizzazione di massa
con la Fiat 500 che usci nel 1955, la 500 del 1957,
poi arrivò la 1100.  Dopo
scooter e biciclette arrivarono appunto le 4 ruote
e le strade italiane cominciarono ad affollarsi
di automobili. Per dare un’idea del divario che
c’era tra Nord e Sud, anche per un mezzo di locomozione
così modesto come la bicicletta, nel 1950 al Nord
c’erano almeno 10 milioni di biciclette, al Sud
nemmeno un milione. Dopo
scooter e biciclette arrivarono appunto le 4 ruote
e le strade italiane cominciarono ad affollarsi
di automobili. Per dare un’idea del divario che
c’era tra Nord e Sud, anche per un mezzo di locomozione
così modesto come la bicicletta, nel 1950 al Nord
c’erano almeno 10 milioni di biciclette, al Sud
nemmeno un milione. Una classe politica un po’ distratta Tutti questi fenomeni trovarono impreparata e sorpresero gran parte della classe politica di allora. Non si erano valutati in tutta la loro portata gli effetti delle innovazioni tecnologiche adottate via via nei principali complessi industriali. Inoltre non si erano percepite o valutate appieno le trasformazioni che stavano avvenendo nel Nord Ovest, il Nord-Est e in altre regioni del centro, dove si stava formando un ceto di piccoli e piccolissimi imprenditori e anche di provetti artigiani specializzati, che provenivano in molti casi, non soltanto in Emilia, dalle file del ceto contadino. Figli o essi stessi mezzadri, affittuari, piccoli fittavoli, coltivatori diretti, che abbandonavano i campi o che facevano attività di part-time fra i campi e il laboratorio o la piccola impresa. Dopo l’Italia delle grandi Imprese, si affermò l’Italia delle piccole imprese. E poi c’era il Sud. Già si erano cominciati a formare dei distretti industriali specializzati a livello territoriale, in Veneto e in Emilia, in Toscana e nelle Marche. Grazie al recupero della stabilità monetaria, il costo del denaro rimaneva contenuto, ancora grazie ad una forte crescita dei risparmi e dei depositi nelle banche. Intorno alla fine degli anni ’60 la media del risparmio depositato presso le banche, era pari alla somma delle medie, registrate in Germania, Francia e Inghilterra. Il nostro Paese continuava ad accumulare forti risparmi, la gente era prudente nel valorizzarli. Ecco perché poi negli anni delle vacche magre a cavallo tra il 1960 e il ‘70 il nostro Paese riuscì a galleggiare e a venirne fuori senza troppa fatica. Questo straordinaria caratteristica si è protratta fino ai giorni nostri e sarà la vera leva che consentirà, anche nei momenti attuali di quasi recessione, di non incorrere in difficoltà insuperabili. I limiti della sinistra cattolica e marxista Il basso costo del denaro favoriva ovviamente chi avesse voglia di intraprendere, di mettere su una bottega, di mettere su un laboratorio, perché tutto questo in effetti non comportava degli eccessivi gravami. Fu una sorpresa per la classe politica anche la crescita dei consumi privati non più di prima necessità. Nell’opposizione di sinistra e in una parte del mondo cattolico (la sinistra democristiana, quella che si richiamava a Dossetti), e nella stessa Chiesa era ancora presente una immagine pauperistica del nostro Paese. Quella che avevamo ereditato nel secondo dopoguerra e che ci si ostinava a considerare il tratto caratteristico di un italiano che invece era in gran parte voluto. La Chiesa temeva che l’espansione dei consumi riducesse la frequenza delle pratiche religiose, che si creasse un genere di modernità che avrebbe distratto la gente dalle pratiche e dai precetti della religione. Il Partito Comunista e non solo, considerava che il capitalismo italiano fosse l’anello più debole del capitalismo occidentale, e che prima o poi avrebbe tirato le cuoia o si sarebbe estinto per incapacità. La prospettiva, fondata su di un ideologismo che non si è mai estinto, che anche in Italia si diffondesse un modello di consumi come quello americano, che avrebbe potuto americanizzare la mentalità e la psicologia degli italiani, portava al paradosso che i più sospettosi sul miglioramento economico della povera gente, fossero proprio quelli che si ritenevano i loro rappresentanti politici, oltre, appunto, alla Chiesa. Fortunatamente le cose sono andate proprio così e nonostante una certa fedeltà di partito nel segreto delle urne, nella vita reale la gente, anche quella che ha continuato negli anni a votare comunista, non ha cessato mai di americanizzarsi. Così, quando nelle sale cinematografiche apparve nel 1960 un film: la Dolce Vita di Federico Fellini, che sembrava intonato ai vaporosi sogni di benessere e di evasione dell’italiano medio, l’accoglienza fu assolutamente negativa da parte di quei settori. Ma nel 1960 il tempo in cui l’Italia era ridotta allo stremo, in cui si faceva la fame e si viveva in tutte le ristrettezze e le privazioni dei primi anni ’50, era ormai un pallido ricordo. Anche se il nostro era un paese ancora in bilico, perchè ancora forte era l’influenza nei costumi e nella psicologia collettiva, di una cultura popolare tipica del mondo contadino e anche l’influenza di certi valori e di certi rituali, per così dire tradizionali: i legami di parentela, le reti di solidarietà familiare, la raccomandazione del Parroco o del notabile di turno, la proverbiale arte di arrangiarsi la ruvida furbizia ereditata dal mondo contadino, il controllo sociale del vicinato. Tutto questo e altro ancora continuavano a condizionare la vita e i modelli di comportamento individuale di molta gente. Gli italiani hanno voglia di cambiare e crescere  In
sostanza, quello che stava avvenendo nella penisola
era una trasformazione per certi aspetti rivoluzionaria
sul piano sociale e sul piano economico, ma a volte
in sordina sul piano culturale, sul piano dei costumi,
a causa della potente azione di freno esercitata
congiuntamente, anche se da opposte visioni, da
parte della Chiesa e del Partito Comunista più forte
in occidente. In
sostanza, quello che stava avvenendo nella penisola
era una trasformazione per certi aspetti rivoluzionaria
sul piano sociale e sul piano economico, ma a volte
in sordina sul piano culturale, sul piano dei costumi,
a causa della potente azione di freno esercitata
congiuntamente, anche se da opposte visioni, da
parte della Chiesa e del Partito Comunista più forte
in occidente. Una testimonianza di questa fase di transizione è segnata dall’intreccio ibrido fra la persistenza di antiche consuetudini con mode ed usanze spesso orecchiate dall’estero. Tutto questo lo si può ritrovare nel passaggio fra il cinema neo-realista e quel genere che venne definito “commedia all’italiana”. Si trattava di un genere cinematografico, che appunto cominciò ad imporsi nei nostri schermi alla fine degli anni ’50, per poi avere grande fortuna nel corso degli anni ’60, che per tanti versi era l’espressione e lo specchio di una società ambivalente in bilico appunto tra il vecchio e il nuovo, di una società in parte ancora sparagnina e frugale, in parte proiettata verso il benessere con l’appetito dell’adolescente, come ebbe felicemente a definire il fenomeno Raffaele Mattioli il mitico banchiere della Banca Commerciale Italiana. Questo era lo spirito e la voglia del tempo, una voglia di divertirsi, di lasciare alle spalle tutte le sofferenze e le privazioni del passato, appunto con l’appetito dell’adolescente. La nostra in gran parte era perciò una società provinciale e codina, attardata su viete convenzioni, ma anche alla rincorsa di tutto ciò che sapesse in qualche modo di moderno, anche nei suoi aspetti più eclatanti e più superficiali. E intanto era cominciata l’era dello spettacolo, l’era dei cantautori e l’era del rock. Va ricordata una canzone simbolo di allora: “Volare” di Domenico Modugno al Festival di Sanremo del 1958.  Volare
è la canzone simbolo di questo periodo e da l’idea
appunto di un’Italia che va inanellando un successo
dopo l’altro, che sta ascendendo nel firmamento
dell’economia, sta entrando e sta facendo ingresso
nel novero dei paesi più industrializzati. Volare
è la canzone simbolo di questo periodo e da l’idea
appunto di un’Italia che va inanellando un successo
dopo l’altro, che sta ascendendo nel firmamento
dell’economia, sta entrando e sta facendo ingresso
nel novero dei paesi più industrializzati. La via tortuosa allo sviluppo Questo aspetto ambivalente, contraddittorio, duplice, della società italiana, si ritrova anche nel sistema economico, perché accanto alle aziende che marciavano con le proprie gambe senza privilegi di sorta, ce n’erano anche altre che godevano di corpose rendite di posizione, e di profitti monopolistici. D’altro canto è anche vero che allo sviluppo tumultuoso, repentino di quegli anni, aveva concorso anche una buona dose di spregiudicatezza collettiva. Non si trattava di una de-regulation.  Si
tendeva a bypassare “provvisoriamente” tutto ciò
che ostacolasse lo sviluppo. E da parte dello Stato
non si provvedeva a mettere in piedi strumenti normativi
efficaci di disciplina, di accertamento dell’economia. Si
tendeva a bypassare “provvisoriamente” tutto ciò
che ostacolasse lo sviluppo. E da parte dello Stato
non si provvedeva a mettere in piedi strumenti normativi
efficaci di disciplina, di accertamento dell’economia.Enrico Mattei non avrebbe costruito l’ENI, con certe restrizioni burocratiche di oggi! Da qui una trafila di evasioni fiscali, vaste sacche di lavoro nero che allora riguardava italiani e non immigrati, discriminazioni politiche sui luoghi di lavoro, in genere a scapito dei militanti e dei sindacalisti di sinistra, ma non soltanto di quelli, anche la Cisl non è che godesse allora di molta fortuna. E poi manomissioni del territorio, nonostante che il problema ambientale fosse già sul tappeto. Il fatto è che non c’era una sensibilità, una cultura del pubblico per questi problemi. Sarebbe infatti spettato alla classe politica di adottare appropriate misure e disposizioni legislative, che prevenissero queste e altre anomalie, che del resto erano incompatibili con le regole di un’autentica economia di mercato. Una domanda viene spontanea. Il processo di sviluppo di quegli anni sarebbe stato così rapido e così intenso, qualora non fosse avvenuto a briglie sciolte, senza argini posti dal potere pubblico? Per la verità bisogna ricordare che la Banca d’Italia fu l’unica istituzione a porre dei paletti, e questa fu una fortuna per noi, per mantenere la domanda interna a un livello in linea con l’equilibrio della Bilancia dei pagamenti. In sostanza per evitare spinte inflazionistiche, come poi abbiamo avuto tra gli anni ’80 e ’90. E c’è da chiedersi infine se sarebbe stato possibile porre le premesse di un’economia aperta agli scambi, dopo che per tanti anni gran parte della nostra industria era vissuta nelle serre del protezionismo doganale, qualora non si fosse venuto a creare una sorta di sistema economico dualistico, diviso al suo interno fra un settore d’avanguardia particolarmente premiato da apposite agevolazioni, e un settore invece confinato un po’ nelle retrovie. Fu infatti grazie alla crescente disponibilità di investimenti e di incentivi a condizioni più vantaggiose, e non solo per indubbie capacità imprenditoriali che non mancavano naturalmente, che ebbe modo di affermarsi un settore industriale di punta, più dinamico, più competitivo, aperto ai mercati, specializzato in beni di consumo durevoli e in grado quindi anche di autofinanziarsi. Fatto sta che soltanto fra il 1961 e il 62 cominciò ad affermarsi in sede politica l’esigenza di introdurre dei correttivi, di attuare alcuni provvedimenti che evitassero l’aggravamento del dualismo tra Nord e Sud, che assecondassero l’ammodernamento dell’agricoltura, che era rimasta la parente povera in quegli anni. Era avvenuto che un paese esportatore di prodotti agricoli come era il nostro, era diventato nel frattempo un paese importatore di prodotti agricoli. Avevamo un forte deficit nella bilancia agro-alimentare. Ciò significa che l’agricoltura oltre che ad essere stata abbandonata da milioni di braccia, non aveva avuto degli incentivi tali per realizzare delle innovazioni. E poi c’era il problema di eliminare le speculazioni immobiliari, sviluppatesi a seguito di forti ondate immigratorie. Roma ne era un problema lampante, ma non solo Roma. E poi c’erano da rimuovere condizioni ormai intollerabili, insopportabili di dominanza oligopolistica nel settore dei servizi pubblici, primo fra tutti l’elettricità. Le bollette erano sempre più care ed erano diventate in pratica uno dei gravami che più pesava sulla gestione del bilancio familiare. E c’erano anche altri settori di interesse collettivo come il sistema ospedaliero e sanitario, ma anche i trasporti urbani su cui occorreva in qualche modo intervenire per evitare che questi costi eccessivi riducessero sostanzialmente il potere di acquisto delle famiglie. Si afferma il centro-sinistra. La nazionalizzazione dell’energia elettrica  In
verità non è che prima di allora fossero mancate
istanze, sollecitazioni a favore di misure di questo
genere. In particolare si era distinto in questa
azione, un gruppo di economisti, politici, intellettuali,
riunito intorno al settimanale il Mondo diretto
da Mario Pannunzio. Però questo sodalizio, che pure
era autorevole perché aveva dei nomi prestigiosi,
non aveva di per sé una forza politica per indurre
la classe di governo a cambiare registro e a intraprendere
una politica di serie riforme. A rompere il ghiaccio
fu la Democrazia Cristiana. In
verità non è che prima di allora fossero mancate
istanze, sollecitazioni a favore di misure di questo
genere. In particolare si era distinto in questa
azione, un gruppo di economisti, politici, intellettuali,
riunito intorno al settimanale il Mondo diretto
da Mario Pannunzio. Però questo sodalizio, che pure
era autorevole perché aveva dei nomi prestigiosi,
non aveva di per sé una forza politica per indurre
la classe di governo a cambiare registro e a intraprendere
una politica di serie riforme. A rompere il ghiaccio
fu la Democrazia Cristiana.Dopo un sofferto dibattito prevalse la tesi di Fanfani e Moro che la DC, contrariamente a quanto era avvenuto fino ad allora, dovesse assumere in prima persona la gestione dello sviluppo economico, in modo da ridurre gli squilibri territoriali e le diseguaglianze sociali. Questo comportava l’apertura ai socialisti, cioè una governo di centro-sinistra, appunto, con il partito di Nenni impegnato nel governo con responsabilità ministeriali. Riccardo Lombardi pose una pregiudiziale perché i socialisti potessero entrare a far parte della coalizione governativa: la nazionalizzazione dell’Energia Elettrica. Lombardi, ma non solo lui, riteneva che la nazionalizzazione dell’energia elettrica avrebbe mutato radicalmente il rapporto tra potere politico e potere economico. Cosicché il potere politico sarebbe stato in grado di gestire e indirizzare lo sviluppo economico secondo finalità di interesse collettivo. Certamente, quello dell’industria elettrica era uno dei principali punti di attacco per una politica di riforme. In effetti le società elettriche con a capo l’Edison, erano allora il principale gruppo di interesse finanziario, industriale del capitalismo italiano. Non lo era la Fiat, non lo era la Montecatini. Lo era invece la Edison di Giorgio Valerio, con una serie di alleanze che vedevano insieme alla Edison, la Toscana-Selt Valdarno, la Roma Elettricità, la Sme nel Sud Delle 1200 società, 6-7 erano i colossi, ma il sistema era estremamente frammentato, e questo era fonte di sprechi ed inefficienze. 1200 erano le società elettriche, senza contare le aziende elettriche municipalizzate, istituite da Giovanni Giolitti nel 1903. Inoltre questi gruppi economici, intuito da tempo che stava per avvicinarsi una tempesta sul loro capo, da un po’ d’anni avevano cessato di fare investimenti in nuove centrali, un’altra ragione questa delle diseconomie esterne che ora minacciavano addirittura lo sviluppo e l’espansione delle potenzialità dell’industria italiana. Queste imprese si impegnarono in una battaglia durissima, di retroguardia, sostenute da gran parte della stampa italiana foraggiata da Valerio il quale aveva rapporti quasi collaterali con molti organi di stampa. Naturalmente l’obiettivo era quello di alzare il prezzo. E in effetti la loro battaglia di retroguardia ebbe successo perché fu necessario sborsare quasi immediatamente delle forti indennità per l’espropriazione di queste imprese. L’Enel nacque senza un fondo di dotazione e dovette assumersi il carico di queste indennità, indebitandosi a sua volta. Per dare un’idea di quanto gigantesca fosse stata quella operazione finanziaria, che avvenne nel 1963, basta ricordare che l’Enel ha finito di far ei conti, soltanto 4-5 anni fa, dopo 40 anni. Il fallimento della programmazione economica La nazionalizzazione dell’energia elettrica fu anche l’atto di battesimo di quella che venne definita la politica di programmazione economica. Però questa politica conseguì solo dei risultati parziali, contraddittori e comunque, non corrispondenti a quelle che erano state le aspettative originarie. I padri della politica di programmazione erano stati i socialisti, e in particolare Antonio Giolitti, Ugo la Malfa, Pasquale Saraceno. Una serie di dissidi interni alle varie correnti della DC e alla nuova coalizione di centro-sinistra fra DC, Socialdemocratici, Repubblicani e Socialisti, paralizzò quelle che avrebbero dovuto essere le riforme più importanti per corrispondere alla domanda sociale di una società che era cresciuta, che era più esigente e in cui i sindacati dal 1962 avevano cominciato a riconquistare voce nelle fabbriche, almeno nei principali gruppi industriali. Queste riforme erano: la riforma urbanistica, a cui era legata anche la riforma della edilizia popolare, l’eliminazione delle speculazioni immobiliari, la riforma del sistema sanitario che riguardava la costruzione di nuove strutture ospedaliere e ambulatori, soprattutto nelle grandi città dove stava ammassandosi una grande ondata di immigrazione, di gente che aveva bisogno di essere assistita. C’era ancora il problema delle scuole elementari e il problema degli asili. Una delle politiche della programmazione fu la riforma Moro della scuola media. Ma si chiedeva anche lo sviluppo di alcuni servizi di pubblica utilità soprattutto quella dei trasporti secondari e delle linee dei pendolari. Tutte queste riforme non andarono in porto o andarono solo parzialmente in porto, ma una della ragioni del fallimento sostanziale della politica di programmazione fu il fatto che emersero le vistose carenze dell’amministrazione pubblica nell’opera di coordinamento e di gestione degli strumenti operativi previsti dai vari piani di programmazione, che erano piani quinquennali, elaborati in sede ministeriale. Avevamo una macchina dell’amministrazione pubblica legata a procedure formaliste, che non era stata creata per diventare la protagonista di una politica di programmazione economica. Così vennero ponendosi le premesse di un’ondata di insoddisfazione, di malessere sociale, che sarebbe poi sfociata per varie altre concause, nell’autunno caldo del 1969 ed in un più generale moto di contestazione che non riguardò solo l’università, ma riguardò i quartieri, soprattutto il nord, riguardò periferie, riguardò alcuni settori anche operai e impiegatizi. Venne da allora determinandosi una situazione di instabilità politica che avrebbe lacerato la coalizione di centro-sinistra, ma non solo. Il Partito comunista Anche la società italiana ne rimase profondamente segnata e ne paghiamo ancora il prezzo.  Chi
soffiava sul fuoco, attraverso una potente macchina
organizzativa, era il Partito Comunista Italiano,
ancora proteso verso orizzonti rivoluzionari (poi
rivelatisi virtuali). A prima vista sembrerebbe
che una opposizione politica che fa il suo mestiere
debba meritare un plauso. Ma in Italia le cose andarono
un po’ diversamente da quella che avrebbe dovuto
essere una normale dialettica democratica. Infatti
il Partito Comunista operava alle dirette dipendenze
della URSS, di cui eseguiva le direttive, e che
provvedeva direttamente al finanziamento della sua
imponente struttura. Quindi, in quanto sudditi di
uno Stato straniero, i suoi militanti consideravano
i non comunisti, non come cittadini che avevano
idee diverse dalle loro, ma come dei nemici. Non
da rispettare voltairraniamente, ma da odiare e,
per molti, poi trasmigrati nelle Brigate Rosse,
anche da eliminare. Chi
soffiava sul fuoco, attraverso una potente macchina
organizzativa, era il Partito Comunista Italiano,
ancora proteso verso orizzonti rivoluzionari (poi
rivelatisi virtuali). A prima vista sembrerebbe
che una opposizione politica che fa il suo mestiere
debba meritare un plauso. Ma in Italia le cose andarono
un po’ diversamente da quella che avrebbe dovuto
essere una normale dialettica democratica. Infatti
il Partito Comunista operava alle dirette dipendenze
della URSS, di cui eseguiva le direttive, e che
provvedeva direttamente al finanziamento della sua
imponente struttura. Quindi, in quanto sudditi di
uno Stato straniero, i suoi militanti consideravano
i non comunisti, non come cittadini che avevano
idee diverse dalle loro, ma come dei nemici. Non
da rispettare voltairraniamente, ma da odiare e,
per molti, poi trasmigrati nelle Brigate Rosse,
anche da eliminare. L’Italia si trovò così divisa in due. Infatti, a sostegno di questa identità politico-culturale, pur non condividendone le ricette politiche, si schierarono ingenuamente ampi settori della società italiana non comunista, a cominciare da alcuni settori cattolici (che arrivarono anche a candidarsi con i comunisti, autodefinendosi indipendenti di sinistra: gli utili idioti, come vennero chiamati), per arrivare ad alcuni ambienti del Partito Socialista (che pagò anche con una scissione pilotata e finanziata dal PC, l’autonomia che Nenni aveva scelto), grandi giornali (Corriere della Sera), giornalisti e intellettuali. Il disegno comunista di egemonizzare la società fallì ben prima della caduta del muro di Berlino, perché dall’altra parte con c’era una dittatura, ma democristiani e socialisti che quanto a democrazia non prendevano lezioni da nessuno. Non è una dimenticanza la mancanza di riferimenti ad una partecipazione del Partito Comunista Italiano al prodigioso sforzo di sviluppo e ricostruzione degli anni 50 e 60.  Questa
partecipazione semplicemente non ci fu e non ci
sarà nemmeno dopo. Questa
partecipazione semplicemente non ci fu e non ci
sarà nemmeno dopo. Sembra lecito domandarsi di cosa si sentano fieri i comunisti vecchi e nuovi, sempre lontani e assenti da ogni grande processo di modernizzazione. Oggi cavalcano una realtà che non hanno contribuito a formare, ma se mai a frenare. Rivendicano un ruolo nel processo di crescita che non hanno mai avuto, e se mai ostacolato. Non va dimenticato, infatti, che gli anni di piombo sono una conseguenza anche del clima sciagurato instaurato nel dopoguerra. Oggi, ormai orfani dell'Unione Sovietica, si scoprono nazionalisti, cantano l'Inno di Mameli, dopo averlo bandito per decenni, parlano di "patria" dopo avere accomunato questo termine al fascismo, sbandierano il tricolore dopo averlo offeso ancora quale simbolo fascista. Riscoprono Fellini, Totò e Alberto Sordi, oggetto per decenni di critiche feroci e, ancora peggio, cariche di supponente disprezzo. Ma questo è un altro complesso spinoso capitolo della storia dell’Italia repubblicana. |