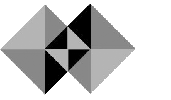Racconti di medici condotti di altri tempi
|
Il Dottorino e la Domenica del Corriere Raffaello Setteposte da "Inediti" Quando il dottorino fu chiamato per una delle solite visite urgenti, in quel pomeriggio d'ottobre, pioveva a dirotto. Prima di avviarsi, sapendo quanta strada avrebbe dovuto percorrere a dorso di mulo, pensò bene di infilarsi l'enorme impermeabile di tela cerata che gli aveva regalato il suocero, esperto conoscitore dei disagi ai quali era costretto colui che esercitava la missionaria opera di medico in quelle zone di montagna. Allora, in mezzo a quei monti, non c'erano le strade che ci sono oggi costruite con i contributi ottenuti per mezzo di compiacenti parlamentari in cerca di voti tra quelle laboriose e modeste popolazioni. Bisognava viaggiare su per gli stretti e pericolosi sentieri di montagna, sul groppone del testardo mulo o su quello del lento e rassegnato asinello. La fuoriserie pronta per il dottorino, in quella piovosa giornata, era appunto un bel mulo, robusto, nato ed allevato in proprio sul posto e quindi padrone degli impervi sentieri, bardato con una impeccabile sella di tipo maremmano, nuova di zecca. A ragione poteva paragonarsi alla lussuosa macchina che oggi adoperano in quelle zone i benestanti e i signori. Infatti colui che aveva chiamato il medico era benestante. Alto, biondo, sulla trentina con una certa distinzione nei modi e nel portamento, pur essendo nato e vissuto tra i monti. Apparteneva ad una delle famiglie più facoltose del Comune ed aveva sposato una giovane maestra che qualche anno prima era capitata ad insegnare nella frazione dove ora viveva. Del nostro uomo i maligni, bene informati, narravano episodi piccanti. Raccontavano che la moglie spesso si svegliava durante il sonno in un bagno di orina per enuresi notturna di cui soffriva lo sposo che oltre tutto, sempre secondo i maligni, non adempiva perfettamente ai suoi doveri coniugali. L'ammalata per la quale il dottore affrontava tutto quel diluvio era appunto la maestra, una donna anche lei sulla trentina, non brutta, dai lineamenti abbastanza fini, dagli occhi intelligenti con un lieve strabismo. Avvolto nell'impermeabile che lo copriva fino ai piedi ebbe inizio il viaggio. Si procedeva lentamente a causa della pioggia che rendeva il terreno viscido e sdrucciolevole e perché il viottolo si arrampicava maledettamente. Il proprietario del mulo seguiva a piedi e nei punti più faticosi si faceva trainare attaccandosi alla coda dell'animale. La pioggia insistente non permetteva la solita chiacchierata sul più e sul meno; camminavamo in silenzio, ognuno era preso dai suoi propri pensieri . Il medico malediva tutto quel diluvio ed intanto riandava col ricordo ai primi giorni di quella sua vita professionale in quel posto di montagna. Finito il suo primo interinato in una zona molto più comoda, lo aveva accompagnato lassù un amico di infanzia che possedeva una potente moto americana con sidecar. Aveva sistemato dinanzi alle ginocchia una valigia di fibra dove c'era un po' di tutto e poco di tutto: dai libri più indispensabili all'abito delle feste e la biancheria intima. Avevamo impiegato diverse ore per arrivare e quando fummo a destinazione l'accompagnatore giurò che alla fine del mese sarebbe tornato a riprendere l'amico dottore perché troppa solitudine, troppo disagio e troppi monti c'erano tutt'intorno quasi a togliere il respiro. Ma le cose andarono diversamente; il medico prima che finisse quel mese di interinato aveva incontrato colei che adesso é sua moglie. Avevano sposato il 29 dicembre 1941; c'era ancora la guerra. Si erano sistemati in una condotta che aveva vinto, ma il passaggio del fronte aveva distrutto ogni cosa su quel paese appollaiato in cima ad un cucuzzolo sui primi contrafforti della linea gotica. Aveva quindi dovuto ripiegare ad esercitare la sua professione nel paese di sua moglie dove lo accolsero in casa i suoceri. Ed ora assolveva alle sue mansioni di medico in quelle zone attendendo che fossero riaperti i concorsi per rientrare in possesso di una sua condotta. Erano giunti così, ognuno immerso nei propri pensieri, a metà della strada. Continuava a piovere. Il mulo, benché forte e robusto, arrancava a fatica; ormai da lontano si scorgeva l'abitazione nella quale si trovava l'ammalata. Ad un tratto l'animale sembrò scivolare: il pensiero che corse velocemente nella testa del medico fu che se il mulo fosse caduto, le sue gambe sarebbero rimaste fratturate sotto quella bestia enorme. Una decisione fulminea: una alzata sulle staffe, un tuffo a pesce lontano dalla bestia che stava abbattendosi al suolo. Fu un tutt'uno e buon per lui che non pensò minimamente alla solita spronata e tirata di redini come aveva fatto altre volte in simili occasioni. Mentre stava rialzandosi dal mare di fango nel quale si era gettato, volgendosi verso l'animale, che faceva sforzi enormi per rialzarsi, si accorse con grande sbalordimento che sotto la pancia del quadrupede scoccava una lingua di fuoco, una scarica elettrica. Comprese allora perché saltando, aveva avvertito un tremolio in tutto il corpo e particolarmente alla lingua. Il proprietario che procedeva a qualche metro di distanza e che non si era accorto di nulla, visto a terra il mulo, correva disperatamente verso la coda dell'animale per aiutarlo a rialzarsi, mentre il medico con urla e gesti gridava di non toccarlo. E fu una fortuna, perché l'animale dopo qualche attimo di vitalità si stese esanime, stecchito. Aveva posato le zampe sui fili della corrente elettrica che giacevano a terra in mezzo al fango di una pozzanghera. Alcuni tagliatori di legna, più a monte, abbattendo una quercia avevano provocato il guaio senza rendersi conto del pericolo al quale avrebbero esposto eventuali passanti. Il dottore, pallido per lo spavento, assisteva ora alla scena di disperazione del proprietario che ad alta voce, piangendo a dirotto, gridava con quanto fiato aveva: Hanno ammazzato il mio mulo, hanno ammazzato il mio mulo. A nulla servivano le parole di conforto del dottore che gli faceva osservare che in fin dei conti il mulo era una bestia e che loro due potevano essere distesi a terra. Intanto da un vicino casolare erano accorse alcune persone. Dalle grida udite, pensavano al peggio. Cercavano di consolare il proprietario che continuava a gridare. Invitarono il medico in casa per togliersi il fango che aveva indosso, rallegrandosi dello scampato pericolo e della felice idea che aveva avuto lanciandosi. Nel frattempo i due responsabili della caduta dei fili, udite le urla, ma non distintamente ciò che era accaduto, si erano dati a correre verso il luogo fatale: vedere il mulo morto, il padrone che piangeva e non scorgere il medico (sapevano che doveva recarsi dall'ammalata) fu come intuire che era successo l'irreparabile. Proseguirono quindi senza fermarsi la loro corsa verso il paese, gridando a tutta voce lu medicu, lu medicu, poveretti noi . Il dottore intanto riavutosi dallo spavento, era salito in groppa ad un somarello che gli avevano messo a disposizione quelli del casolare ed aveva affrontato l'ultimo tratto di strada. L'ammalato stava meglio del curante che fu costretto a spiegare il perché del suo arrivo in ciucherello anziché in mulo: "Aveva preso un puntiglio e non aveva voluto più proseguire". Non volle allarmare nessuno narrando la vera causa; atti isterici avrebbero ritardato il suo ritorno a casa perché ora di questo si preoccupava il dottore. Tornare prima possibile in paese dove forse a quell'ora erano già rientrati i due colpevoli. Infatti se l'errata notizia delle disgrazia fosse arrivata alle orecchie di sua moglie in stato di gravidanza, dopo sei anni di attesa, avrebbe provocato veramente un danno. Abbandonò quindi il somaro e si diede a corsa precipitosa verso il fondo valle incespicando, cadendo, infangandosi fino alla punta dei capelli. Dal fondo valle risalì quasi correndo verso il paese e all'ingresso vide venirgli incontro a braccia aperte incredulo, trasognato uno zio della moglie. La fortuna aveva voluto che i due si fossero imbattuti per primi nello zio, che da uomo previdente ed autoritario li aveva acciuffati e chiusi in una stanza perché non avessero propagato così repentinamente la notizia. Stava appunto accingendosi a venire a controllare di persona l'accaduto. Inutile descrivere la gioia. Qualcuno, dietro suggerimento del medico, si interessò di passare casa per casa pregando di non fare riferimento dell'accaduto in presenza di sua moglie. Fu così che al termine di sei mesi la casa fu allietata dalla nascita di una bella bambina e dopo qualche settimana dall'accaduto, il dottorino, ebbe a sua insaputa, l'onore di una pagina illustrata nella Domenica del Corriere. |
Renato Fucini da "Le veglie di Neri" A dodici anni lasciò, per gli studi, la casa paterna e, solo, lontano da' suoi, in quell'età nella quale, pur vagheggiando lo spazio, sentiamo sempre il bisogno d'esser covati dalla mamma come rondinotti prima di fidarsi al volo, dovette avventurarsi nel turbine della vita a farvi da uomo quasi innanzi d'esser ragazzo. «Ma fu la mia salute e vinsi!», mi diceva spesso con orgoglio, «vinsi, perché armato, fino dall'infanzia, di quell'educazione larga ma onesta, qualche volta romantica ma sempre vigorosa, che i nostri vecchi liberali davano ai loro figli, allevando uomini forti d'animo e di braccio, non ganimedi parrucchieri ed isterici.» «O senti», mi diceva una notte mentre lo vegliavo ammalato, «senti un saggio originale del metodo, una scenetta di famiglia che, dopo tanti anni, ho sempre fresca qui nella memoria fra i miei ricordi più dolci. Mio padre, medico in un comunello di montagna, guadagnava, quando io ero ragazzetto, cinque paoli al giorno, che oggi sarebbero due lire e ottanta centesimi. Coi miseri incerti di qualche consulto, di qualche operazioncella e di qualche visita fuori della condotta si può calcolare che il suo guadagno arrivasse a circa quattro lire, piuttosto meno che più. Con queste doveva mantenere decorosamente la sua famiglia, un cavallo, un servitore, e me all'Università... Vado per le leste e perché sento che il discorrer troppo mi aggraverebbe il petto e tu forse ti annoieresti. Una sera dopo le vacanze del Natale, avevo allora diciassette anni, torno a Pisa con la mia mesata d'ottanta lire nel portafogli. Il rivedere gli amici mi mette allegria, vado a cena con una brigata di quei bontemponi, bevo, mi elettrizzo, giro cantando per le vie della città fino ad ora tarda, e da ultimo casco in una casa da giuoco, dove in un paio d'ore lascio tutta la mesata, più trenta lire di debito con un amico che me le prestò. Una piccolezza, se vogliamo, ma una piccolezza che per le condizioni della mia famiglia era grave, forse troppo grave. Arrivato nella mia cameruccia, mi buttai sul letto, ma non potei dormire. Sbuffai, mi svoltolai continuamente senza trovar riposo. Ebbi qualche breve dormiveglia, ma fu peggio. Brillanti, assassini, miniere d'oro, coltellate, mostri paurosi, corse a perdita di fiato per deserti a perdita d'occhio, urli, fischi, imprecazioni... sognai un po' di tutto; e finalmente un grande scossone e tanto d'occhi spalancati, grondante di sudore. «Che si fa?», pensavo. «Chiedo a qualche amico? Scrivo a qualche parente? a mia madre? a mio...? Ah!... qui bisogna uscirne presto. Un atto di contrizione, un po' di dramma, quattro urlacci, due tonfi, magari... e perché no? magari una fitta di scapaccioni, e tutto è finito, e non ci si pensa più.» Salto giù dal letto, mi faccio prestare pochi soldi dal primo amico mattiniero che incontro, mi rincantuccio in un vagone di terza classe, e via a casa. Il viaggio mi fece bene. Parlai continuamente di politica, di guerra e di donne con un associatore di libri che andava a Signa, ed ebbi dei momenti nei quali, sognando sul serio gloria, armi ed amori, in faccia al mio associatore che mi guardava, stava zitto e fumava la pipa, dimenticate le mie miserie, mi sentii quasi orgoglioso d'aver anch'io la prima bravata da raccontare. Ma quando vidi spuntare fra i boschi la torre del mio paesello, eppoi il tetto della mia casa e il fumo che usciva dalla torretta del suo cammino, la baldanza mi cadde e sentii le gambe che mi tremavano. Quand'arrivai a casa, mio padre non c'era. Mia madre si spaventò perché, vedendomi pallido, mi credette malato. «Non ho nulla, sto bene... proprio sto bene.» Il suo viso si rasserenò subito e, fatta forte da questa buona certezza, ascoltò abbastanza tranquilla, mentre preparava il desinare, il racconto che le feci dal canto del fuoco, dove m'ero rannicchiato, scaldandomi alla fiamma che schioccava allegra sotto un paiolo di rape. Quando ebbi terminato: «Figliolo!... io ti domando come si deve fare a dirlo a quell'omo!», esclamò guardandomi sgomenta. Poi dopo una lunga pausa pensosa: «È impossibile! Come vuoi che faccia a renderti ora una mesata, se ce n'ha appena tanti per andare avanti noi?!... Trovarli!... E dopo?... Non c'è carità, in questo momento non c'è carità... Gli sta peggio quel malato e pare che vada a morire...» Io stavo zitto a guardarla, lei si chetò. Il tepore del mio nido, la stanchezza e il mugolìo del vento su per la gola del camino mi conciliarono il sonno e, senza accorgermene, mi addormentai col capo appoggiato sulla spalliera della seggiola. Quando mi destai, vidi mio padre seduto dall'altra parte del focolare, che si asciugava alla fiamma i calzoni fradici di pioggia. Pareva stanco ed era pallido. Tossiva malamente ed aveva schizzi di fango fino sulla faccia. Sentendomi muovere, alzò la testa. «Buon giorno, babbo.» «Buon giorno», mi rispose. E non mi disse altro. Dopo qualche momento si alzò, disse a mia madre d'affrettare il desinare perché aveva bisogno d'escir subito, e andò in camera sua. «Glie l'hai detto?», domandai trepidante a mia madre. Essa mi accennò di sì. «Che ha detto?» «Ha domandato come stavi e s'è messo a leggere.» Il desinare fu nero. I miei vecchi barattarono fra loro poche parole d'affarucci di famiglia, ed io, sempre aspettando una tempesta, che mi avrebbe fatto tanto bene al core per votarlo d'urli, di bile e magari di pianto; per vedere se in una sfuriata trovavo la gretola di non avere tutto il torto io, ebbi a rimanere gelidamente trafitto dalle poche parole che nel tòno usuale e quasi con amorevolezza mi rivolse mio padre. «Beppe l'hai veduto?» (era un suo vecchio compagno di studi che io avevo sempre l'incarico di salutare quando andavo a Pisa). «No...» «Domattina partirai col primo treno... Ti chiamerò presto perché dovrai andare alla stazione a piedi... Del cavallo ne ho bisogno io.» «Sì.» Finito il desinare, andò via. Tornò a sera inoltrata, prese un boccone e andò a letto, dopo avermi fatto con gli occhi stanchi una burbera carezza. La mattina dopo, mi svegliò alle cinque. Era buio, freddo, vento e nevicava forte. Quando uscii di camera, mia madre, già alzata, mi aspettava per dirmi addio. «Gli ha lasciati a te i quattrini?» le domandai sotto voce. «È là fòri che ti aspetta.» Corsi sulla porta e alla luce della lanterna con la quale il servitore ci faceva lume, lì davanti, mio padre già a cavallo, immobile, rinvoltato nel suo largo mantello carico di neve. «Tieni» mi disse, parlando rado e affondandomi ad ogni parola un solco nell'anima. «Prendi... Ora è roba tua... Ma prima di spenderli!... Guardami!...», e mi fulminò con un'occhiata fiera e malinconica. «Prima di spenderli, ricòrdati come tuo padre li guadagna.» Una spronata, uno sfaglio, e si allontanò a capo basso nel buio, tra la neve e il vento che turbinava. |